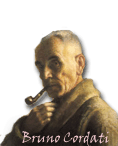 E'
molto difficile per me scrivere di mio padre. L'amore e la lunga
consuetudine confondono: rimangono cose che la memoria sente come
fondamentali; non ne vengono in mente altre, magari le più
importanti, alle quali l'assuefazione ha tolto significato. Inoltre,
di un lavoro che è durato ininterrottamente dalla prima guerra
mondiale agli ultimi anni settanta, tendo a ricordare meglio gli
ultimi decenni: non solo perché più vicini, ma anche
perché una maggior libertà dalla famiglia mi ha consentito
di riannodare con mio padre rapporti più stretti e prolungati. E'
molto difficile per me scrivere di mio padre. L'amore e la lunga
consuetudine confondono: rimangono cose che la memoria sente come
fondamentali; non ne vengono in mente altre, magari le più
importanti, alle quali l'assuefazione ha tolto significato. Inoltre,
di un lavoro che è durato ininterrottamente dalla prima guerra
mondiale agli ultimi anni settanta, tendo a ricordare meglio gli
ultimi decenni: non solo perché più vicini, ma anche
perché una maggior libertà dalla famiglia mi ha consentito
di riannodare con mio padre rapporti più stretti e prolungati.
Così
da qui e da ora, com'è il suo verso naturale, si avvia
e si forma il ricordo, strettamente legato a Barga dove si era
ritirato gli ultimi trenta anni della sua vita. Questo paese è
sempre stato un punto di riferimento del suo pensiero; incanalava
il suo lavoro, gli dava misura e ritmo; era un punto di vista
fermo, familiare, comprensibile. Questo paese: e nel paese, questa
casa dove ora si tiene la mostra. Qui aveva dapprima solo le stanze
dello studio, finché non poté averla, restaurarla,
farne il luogo di raccolta dei suoi quadri.
 Lo
dice bene Ernesto De Martino, che "alla base della vita culturale
del nostro tempo sta l'esigenza di ricordare una patria - per
non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente
nella memoria, a cui l'immagine e il cuore tornano sempre di nuovo,
e che l'opera di scienza e di poesia riplasma in voce universale".
Continuamente tornava alla memoria di mio padre quella Barga piccola
e chiusa della sua infanzia, grigia di pietra, con infissi alle
mura dei suoi nobili palazzi gli anelli di ferro per attaccare
i muli; una vita quotidiana dal ritmo lento, un po' superbo e
malinconico, che è la musica di tanti suoi quadri. Lo
dice bene Ernesto De Martino, che "alla base della vita culturale
del nostro tempo sta l'esigenza di ricordare una patria - per
non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente
nella memoria, a cui l'immagine e il cuore tornano sempre di nuovo,
e che l'opera di scienza e di poesia riplasma in voce universale".
Continuamente tornava alla memoria di mio padre quella Barga piccola
e chiusa della sua infanzia, grigia di pietra, con infissi alle
mura dei suoi nobili palazzi gli anelli di ferro per attaccare
i muli; una vita quotidiana dal ritmo lento, un po' superbo e
malinconico, che è la musica di tanti suoi quadri.
 Così
la sua vita tendeva all'immobilità, al radicarsi sempre
più profondamente, al guardare sempre più da vicino,
sempre più nei particolari; vorrei esser nato platano,
diceva; star fermo, allargarmi sempre più nelle radici.
Diceva che non occorre cercare una veduta storica o panoramica
per trovare il bello: basta sradicare un cespuglietto d'erba,
rovesciarlo, studiare il movimento delle radici, il loro rapporto
con la terra, con i piccoli sassi che esse abbrancano. Gli piaceva
molto quell'aneddoto attribuito a Gonciarov, quando fu chiamato
sul ponte dal capitano della nave, cui sembrava che lo spettacolo
grandioso della tempesta fosse particolarmente adatto a un artista;
Gonciarov guardò in giro corrucciato, brontolò:
un gran disordine! e se ne tornò in cabina. Sempre infastidiva
mio padre lo sforzo visibile nel lavoro, il gonfiarsi, l'ansimare
verso il risultato; sentiva che la forza è dentro, e da
dentro indica quel minimo che occorre per arrivare, quello scarto
delicato, quel rapporto che fa sì che il quadro sia "a
posto". Così
la sua vita tendeva all'immobilità, al radicarsi sempre
più profondamente, al guardare sempre più da vicino,
sempre più nei particolari; vorrei esser nato platano,
diceva; star fermo, allargarmi sempre più nelle radici.
Diceva che non occorre cercare una veduta storica o panoramica
per trovare il bello: basta sradicare un cespuglietto d'erba,
rovesciarlo, studiare il movimento delle radici, il loro rapporto
con la terra, con i piccoli sassi che esse abbrancano. Gli piaceva
molto quell'aneddoto attribuito a Gonciarov, quando fu chiamato
sul ponte dal capitano della nave, cui sembrava che lo spettacolo
grandioso della tempesta fosse particolarmente adatto a un artista;
Gonciarov guardò in giro corrucciato, brontolò:
un gran disordine! e se ne tornò in cabina. Sempre infastidiva
mio padre lo sforzo visibile nel lavoro, il gonfiarsi, l'ansimare
verso il risultato; sentiva che la forza è dentro, e da
dentro indica quel minimo che occorre per arrivare, quello scarto
delicato, quel rapporto che fa sì che il quadro sia "a
posto".
 Si
sviluppava così nel suo lavoro quella che lui interpretava
come una tendenza alla semplificazione. Non lo interessavano più
i suoi lavori del periodo pienamente figurativo degli anni venti
e trenta, dipinti in parte a Barga, in parte in Veneto, a Budapest,
a Parigi. Nemmeno lo interessava più il gruppo dei quadri
dipinti in Bulgaria, dove era stato nei primi anni quaranta, e
dove era stato attratto dai vividi colori dei villaggi turchi
e zingari, dalla bellezza solenne delle donne zingare. Ne era
nato il piacere - che appartiene solo a questo periodo - per un
colore e una pasta ricchi e pieni, luminosi, che si era allargato
anche a certi nudi e a certi paesaggi di questo stesso periodo
e luogo. Si
sviluppava così nel suo lavoro quella che lui interpretava
come una tendenza alla semplificazione. Non lo interessavano più
i suoi lavori del periodo pienamente figurativo degli anni venti
e trenta, dipinti in parte a Barga, in parte in Veneto, a Budapest,
a Parigi. Nemmeno lo interessava più il gruppo dei quadri
dipinti in Bulgaria, dove era stato nei primi anni quaranta, e
dove era stato attratto dai vividi colori dei villaggi turchi
e zingari, dalla bellezza solenne delle donne zingare. Ne era
nato il piacere - che appartiene solo a questo periodo - per un
colore e una pasta ricchi e pieni, luminosi, che si era allargato
anche a certi nudi e a certi paesaggi di questo stesso periodo
e luogo.
 Adesso,
tornato a Barga per lo scoppio della guerra, e deciso a non muoversi
più, avviava quel periodo di intenso raccoglimento che
doveva concludersi alla sua morte. La sua riflessione sulla pittura
prendeva una strada tutta diversa. Il figurativo spaziato, pieno
di prospettiva, illusionistico, cedeva via via il passo a un lavoro
i cui eventi si svolgevano tutti alla superficie del quadro, la
cui materia e soggetto era il colore stesso; che non richiedeva
più certo l'osservazione di modelli e paesaggi, ma un ripensamento
profondo di forme, di rapporti in equilibrio delicato e difficile. Adesso,
tornato a Barga per lo scoppio della guerra, e deciso a non muoversi
più, avviava quel periodo di intenso raccoglimento che
doveva concludersi alla sua morte. La sua riflessione sulla pittura
prendeva una strada tutta diversa. Il figurativo spaziato, pieno
di prospettiva, illusionistico, cedeva via via il passo a un lavoro
i cui eventi si svolgevano tutti alla superficie del quadro, la
cui materia e soggetto era il colore stesso; che non richiedeva
più certo l'osservazione di modelli e paesaggi, ma un ripensamento
profondo di forme, di rapporti in equilibrio delicato e difficile.
 Diceva:
voglio avere qui tutto sulla superficie della tela. Ripensando
a grandi tratti allo sviluppo del suo lavoro, si riconosce che
le due guerre mondiali debbono aver costituito due cesure fondamentali
della sua vita. Della prima parlava con riserbo, con quel tono
basso che gli era caratteristico. Erano stati quattro anni di
trincea, e una medaglia al valore presa sul Piave; gli ultimi
due anni al comando di una formazione speciale di ex carcerati,
coi quali si era inteso benissimo. Parlava della pioggia, la cosa
più tremenda, diceva, della guerra in trincea: all'inizio
cercavi di ripararti in qualche modo, in quelle trincee quasi
scoperte, con teli impermeabili o altro; e cominciavi a sentire
l'acqua che ti si infilava nel colletto; quando eri fradicio,
e ormai ogni precauzione era inutile, era quasi una liberazione,
non ci pensavi più. Ma anche i topi erano una piaga, e
bisognava mettere di guardia l'attendente con un bastone, per
poter vincere il ribrezzo e poter dormire. Per il resto, qualche
rapida descrizione: il soldato colpito al cervello, che attacca
a gran voce l'avvio di un ritornello - Affacciati alla finestra...
- prima di cadere fulminato; o il colonnello venuto in visita
alle trincee che dopo aver camminato a lungo chino per ripararsi,
si alza con una mossa naturale per massaggiarsi la schiena indolenzita
e viene preso alla testa; o le lunghe conversazioni con gli austriaci
durante le ore di pausa. Una cosa sola ricordata con una smorfia
di sofferenza: le licenze, la gente che in treno si scostava per
paura dei pidocchi, la gente che faceva la solita vita fin dalle
retrovie, e più ancora verso l'interno. Diceva:
voglio avere qui tutto sulla superficie della tela. Ripensando
a grandi tratti allo sviluppo del suo lavoro, si riconosce che
le due guerre mondiali debbono aver costituito due cesure fondamentali
della sua vita. Della prima parlava con riserbo, con quel tono
basso che gli era caratteristico. Erano stati quattro anni di
trincea, e una medaglia al valore presa sul Piave; gli ultimi
due anni al comando di una formazione speciale di ex carcerati,
coi quali si era inteso benissimo. Parlava della pioggia, la cosa
più tremenda, diceva, della guerra in trincea: all'inizio
cercavi di ripararti in qualche modo, in quelle trincee quasi
scoperte, con teli impermeabili o altro; e cominciavi a sentire
l'acqua che ti si infilava nel colletto; quando eri fradicio,
e ormai ogni precauzione era inutile, era quasi una liberazione,
non ci pensavi più. Ma anche i topi erano una piaga, e
bisognava mettere di guardia l'attendente con un bastone, per
poter vincere il ribrezzo e poter dormire. Per il resto, qualche
rapida descrizione: il soldato colpito al cervello, che attacca
a gran voce l'avvio di un ritornello - Affacciati alla finestra...
- prima di cadere fulminato; o il colonnello venuto in visita
alle trincee che dopo aver camminato a lungo chino per ripararsi,
si alza con una mossa naturale per massaggiarsi la schiena indolenzita
e viene preso alla testa; o le lunghe conversazioni con gli austriaci
durante le ore di pausa. Una cosa sola ricordata con una smorfia
di sofferenza: le licenze, la gente che in treno si scostava per
paura dei pidocchi, la gente che faceva la solita vita fin dalle
retrovie, e più ancora verso l'interno.
 Due
anni, verso il trenta, passati a Gorizia, furono l'occasione di
un riconoscimento minuto del Carso, del San Michele; si ripercorrevano
i camminamenti e le trincee; si vedevano i ragazzi ancora alla
ricerca del ferro interrato. Ne nacquero molti disegni, e un pastello
dei migliori. Due
anni, verso il trenta, passati a Gorizia, furono l'occasione di
un riconoscimento minuto del Carso, del San Michele; si ripercorrevano
i camminamenti e le trincee; si vedevano i ragazzi ancora alla
ricerca del ferro interrato. Ne nacquero molti disegni, e un pastello
dei migliori.
Ma
nel decennio che seguì la guerra fu una vera esplosione
di lavoro. Nei grandi quadri domina come tema la figura umana,
una umanità assorta, colta in un momento di riposo dalla
fatica quotidiana. Pochi paesaggi, e soprattutto, cosa proprio
sua caratteristica, mai panoramici: qualche tratto di tetti, di
grondaie barghigiane, col gusto di sottolineare l'andamento geometrico
delle linee che convergono, divergono, cadono e si innalzano.
 Tutto
questo lavoro ha a parer mio un primo livello di lettura, quello
che tutti coglievano e colgono con emozione, cioè l'evidenza
rappresentativa e l'intenzione tematica. Ma approfondendo l'osservazione
si trovano, aldilà di questo, alcuni caratteri che permarranno
in seguito in lavori apparentemente diversissimi: non solo la
negazione totale della rapidità e dell'abbozzo, ma come
una forza di gravità per cui il quadro consiste in tutte
le sue parti, e ogni forma si esprime come se portasse a compimento
per suo conto tutto un processo di pensiero: un rapporto di colore
tra la parete e le spalle della persona che vi si appoggia, il
verso di una mano d'uomo sul tavolino di un'osteria, un profilo
che si perde nel sonno, vi si cancella e quasi si annulla, una
donna distesa in una calma composizione orizzontale: e cogliamo
la lucentezza della pelle tesa sulle ginocchia abbandonate, il
braccio che si allunga in primo piano quasi a commentare la linea
della bella persona. Tutto
questo lavoro ha a parer mio un primo livello di lettura, quello
che tutti coglievano e colgono con emozione, cioè l'evidenza
rappresentativa e l'intenzione tematica. Ma approfondendo l'osservazione
si trovano, aldilà di questo, alcuni caratteri che permarranno
in seguito in lavori apparentemente diversissimi: non solo la
negazione totale della rapidità e dell'abbozzo, ma come
una forza di gravità per cui il quadro consiste in tutte
le sue parti, e ogni forma si esprime come se portasse a compimento
per suo conto tutto un processo di pensiero: un rapporto di colore
tra la parete e le spalle della persona che vi si appoggia, il
verso di una mano d'uomo sul tavolino di un'osteria, un profilo
che si perde nel sonno, vi si cancella e quasi si annulla, una
donna distesa in una calma composizione orizzontale: e cogliamo
la lucentezza della pelle tesa sulle ginocchia abbandonate, il
braccio che si allunga in primo piano quasi a commentare la linea
della bella persona.
 Questo
senso profondo della composizione, la comprensione della autonoma
importanza di ogni minimo fenomeno è una delle direttrici
del quadro; e fa contrasto con l'intenzione compositiva più
evidente, che si accompagna al tema e lo sottolinea. Questa interna
divaricazione dà ai quadri un loro peso peculiare, un modo
calmo e riposato di occupare lo spazio. A proposito di questo
equilibrio mi viene alla mente una frase di Kandinskij: "naturalmente
ogni opera d'arte è quieta, solo che ai contemporanei riesce
difficile trovare quest'intima quiete (nobiltà). Ogni opera
seria risuona interiormente con le parole, tranquillamente e nobilmente
proferite: sono qui ". Questo
senso profondo della composizione, la comprensione della autonoma
importanza di ogni minimo fenomeno è una delle direttrici
del quadro; e fa contrasto con l'intenzione compositiva più
evidente, che si accompagna al tema e lo sottolinea. Questa interna
divaricazione dà ai quadri un loro peso peculiare, un modo
calmo e riposato di occupare lo spazio. A proposito di questo
equilibrio mi viene alla mente una frase di Kandinskij: "naturalmente
ogni opera d'arte è quieta, solo che ai contemporanei riesce
difficile trovare quest'intima quiete (nobiltà). Ogni opera
seria risuona interiormente con le parole, tranquillamente e nobilmente
proferite: sono qui ".
 Con
Kandinskij però mio padre polemizzò una intera estate,
leggendo Lo spirituale nell'arte. Già il titolo non gli
piaceva, con quel termine spirituale che lo metteva in sospetto.
Mentre condivideva tutte le parti tecniche, di mestiere, gli sembrava
pericolosa l'impostazione del pensiero. Ad esempio, là
dove Kandinskij parla del rischio, per un pittore, di privarsi
della possibilità di determinare una vibrazione interiore
con un oggetto plasticamente rappresentato, mio padre contestava
che questo rischio esistesse: noi viviamo in mezzo a queste forme,
di queste forme e fatta la nostra capacità di vedere, cosa
possiamo rappresentare se non questo? La vibrazione in chi guarda
proviene appunto dal riconoscimento della sua propria esperienza
visiva. Con
Kandinskij però mio padre polemizzò una intera estate,
leggendo Lo spirituale nell'arte. Già il titolo non gli
piaceva, con quel termine spirituale che lo metteva in sospetto.
Mentre condivideva tutte le parti tecniche, di mestiere, gli sembrava
pericolosa l'impostazione del pensiero. Ad esempio, là
dove Kandinskij parla del rischio, per un pittore, di privarsi
della possibilità di determinare una vibrazione interiore
con un oggetto plasticamente rappresentato, mio padre contestava
che questo rischio esistesse: noi viviamo in mezzo a queste forme,
di queste forme e fatta la nostra capacità di vedere, cosa
possiamo rappresentare se non questo? La vibrazione in chi guarda
proviene appunto dal riconoscimento della sua propria esperienza
visiva.
 Era
sua caratteristica ritrarsi da ogni affermazione che presumesse
una qualche sicura conoscenza. Per questo più che i critici
gli piaceva leggere i narratori e i poeti. Aveva un modo particolare
di leggere, un dialogo continuo con lo scrittore; ad esempio non
diceva "guarda com'è bello qui'", ma "guarda
come ha fatto bene"; lo emozionava ogni soluzione tecnica
riuscita, leggeva assaporando i problemi e le soluzioni. Gli piacevano
molto i narratori del novecento, Joyce, Musil, ma lo disturbava
doverli leggere tradotti; perciò passava più tempo
coi francesi, che poteva leggere in lingua - Flaubert, Maupassant,
Proust, ma soprattutto Flaubert - e con gli italiani. Fra gli
italiani, I'opera che ha letto forse più a lungo è
l'Orlando Furioso; l'ultima rilettura fu lentissima, gli durò
per mesi e mesi. Leggeva alla sera, quando la luce per lavorare
era tramontata. Passava dalle sue stanze di studio a quelle di
abitazione, si lavava a lungo le mani sporche di colore e odorose
di acqua ragia, prendeva un tè, e si sedeva soddisfatto
dicendo: io ho lavorato, ora vediamo come ha lavorato lui. Seguiva
con particolare gioia il filone di Astolfo, ed era contento quando
il personaggio rientrava nel racconto. L'unica sua pittura che
nasce direttamente da un libro è proprio un piccolo quadro
affollato e pieno di movimento, Astolfo che fugge a cavallo con
in grembo la testa di Orrilo, mentre Orrilo decapitato lo segue
a ridosso minacciando con le mani alzate. Era
sua caratteristica ritrarsi da ogni affermazione che presumesse
una qualche sicura conoscenza. Per questo più che i critici
gli piaceva leggere i narratori e i poeti. Aveva un modo particolare
di leggere, un dialogo continuo con lo scrittore; ad esempio non
diceva "guarda com'è bello qui'", ma "guarda
come ha fatto bene"; lo emozionava ogni soluzione tecnica
riuscita, leggeva assaporando i problemi e le soluzioni. Gli piacevano
molto i narratori del novecento, Joyce, Musil, ma lo disturbava
doverli leggere tradotti; perciò passava più tempo
coi francesi, che poteva leggere in lingua - Flaubert, Maupassant,
Proust, ma soprattutto Flaubert - e con gli italiani. Fra gli
italiani, I'opera che ha letto forse più a lungo è
l'Orlando Furioso; l'ultima rilettura fu lentissima, gli durò
per mesi e mesi. Leggeva alla sera, quando la luce per lavorare
era tramontata. Passava dalle sue stanze di studio a quelle di
abitazione, si lavava a lungo le mani sporche di colore e odorose
di acqua ragia, prendeva un tè, e si sedeva soddisfatto
dicendo: io ho lavorato, ora vediamo come ha lavorato lui. Seguiva
con particolare gioia il filone di Astolfo, ed era contento quando
il personaggio rientrava nel racconto. L'unica sua pittura che
nasce direttamente da un libro è proprio un piccolo quadro
affollato e pieno di movimento, Astolfo che fugge a cavallo con
in grembo la testa di Orrilo, mentre Orrilo decapitato lo segue
a ridosso minacciando con le mani alzate.
 Il
modo di pensare in cui si radica questa visione dell'arte, della
lettura, della cultura insomma è rilevante per capire il
suo lavoro e la sua stessa concezione di vita. Secondo questo
modo, ogni opera è un evento staccato e unico in sé;
non si vedeva in lui traccia di un piano generale di accumulazione,
per cui un quadro, un libro, una musica dovessero servire anche
da tramite, o anche solo dovessero avere una funzione altra da
sé: anzi, si doveva fare spazio intorno all'opera, isolarla
in modo che potesse assumere tutto il rilievo che le competeva;
nessun altro uso era previsto o consentito. Tutto ciò aveva
lo scopo di portare l'attenzione al modo di lavorare, al come
dell'esecuzione. Ne risulta un modo di avvicinarsi all'opera d'arte
che io chiamerei egualitario, senza rispetto per le graduatorie
e senza fiducia nell'autorità, in cui le uniche regole
sono la lentezza, la cura, l'attenzione. Il
modo di pensare in cui si radica questa visione dell'arte, della
lettura, della cultura insomma è rilevante per capire il
suo lavoro e la sua stessa concezione di vita. Secondo questo
modo, ogni opera è un evento staccato e unico in sé;
non si vedeva in lui traccia di un piano generale di accumulazione,
per cui un quadro, un libro, una musica dovessero servire anche
da tramite, o anche solo dovessero avere una funzione altra da
sé: anzi, si doveva fare spazio intorno all'opera, isolarla
in modo che potesse assumere tutto il rilievo che le competeva;
nessun altro uso era previsto o consentito. Tutto ciò aveva
lo scopo di portare l'attenzione al modo di lavorare, al come
dell'esecuzione. Ne risulta un modo di avvicinarsi all'opera d'arte
che io chiamerei egualitario, senza rispetto per le graduatorie
e senza fiducia nell'autorità, in cui le uniche regole
sono la lentezza, la cura, l'attenzione.
 Così,
sia per il lavoro proprio che per capire il lavoro degli altri,
la ricerca di mio padre era fortemente caratterizzata; non cercava
il bello, ma il serio, il ben fatto, la traccia e lo spessore
della fatica quotidiana, dell'esperienza, della sapienza artigianale:
di ciò che chiamava, riferendosi al proprio lavoro, tribolare.
Su questo quotidiano tribolare, e solo su questo, poteva innestarsi,
come un miracolo, il bello, l'arte; ciò che non viene fatto,
ma viene da sé - e tutta la bravura del cosiddetto artista
consiste nel vedere che è venuto, e non guastarlo. Fu molto
contento, infatti, quando lesse una risposta che l'amato Manzù
aveva dato a Liliana Madeo in una intervista sulla Stampa: "Nello
studio ogni mattina ci vado per un mio bisogno, come bisogno e
mangiare e dormire. Non ci vado mai con l'idea di fare l'opera
d'arte. Se una volta pensassi questo non lavorerei mai più.
Ogni giorno spero che sia la volta buona". Questa risposta
esprimeva appunto la libertà di movimento che si ottiene
depurandosi - o ripulendosi, come diceva volentieri, indicando
così il processo di semplificazione - da rigidezze mentali
e ambizioni sbagliate; una libertà che permette di avvicinarsi
in modo sempre nuovo e aperto al lavoro sia proprio che altrui. Così,
sia per il lavoro proprio che per capire il lavoro degli altri,
la ricerca di mio padre era fortemente caratterizzata; non cercava
il bello, ma il serio, il ben fatto, la traccia e lo spessore
della fatica quotidiana, dell'esperienza, della sapienza artigianale:
di ciò che chiamava, riferendosi al proprio lavoro, tribolare.
Su questo quotidiano tribolare, e solo su questo, poteva innestarsi,
come un miracolo, il bello, l'arte; ciò che non viene fatto,
ma viene da sé - e tutta la bravura del cosiddetto artista
consiste nel vedere che è venuto, e non guastarlo. Fu molto
contento, infatti, quando lesse una risposta che l'amato Manzù
aveva dato a Liliana Madeo in una intervista sulla Stampa: "Nello
studio ogni mattina ci vado per un mio bisogno, come bisogno e
mangiare e dormire. Non ci vado mai con l'idea di fare l'opera
d'arte. Se una volta pensassi questo non lavorerei mai più.
Ogni giorno spero che sia la volta buona". Questa risposta
esprimeva appunto la libertà di movimento che si ottiene
depurandosi - o ripulendosi, come diceva volentieri, indicando
così il processo di semplificazione - da rigidezze mentali
e ambizioni sbagliate; una libertà che permette di avvicinarsi
in modo sempre nuovo e aperto al lavoro sia proprio che altrui.
 E
a ogni tipo di lavoro, non solo a quello dell'arte. Anche come
insegnante rifiutava termini (e intenzioni) come educare, formare,
ecc. Pensava che noi possiamo insegnare a lavorare, non mai a
disegnare, a scrivere, a capire l'arte: questo, se viene, viene,
come il bello, per soprappiù. E
a ogni tipo di lavoro, non solo a quello dell'arte. Anche come
insegnante rifiutava termini (e intenzioni) come educare, formare,
ecc. Pensava che noi possiamo insegnare a lavorare, non mai a
disegnare, a scrivere, a capire l'arte: questo, se viene, viene,
come il bello, per soprappiù.
La
seconda guerra mondiale lo segnò in modo ben più
profondo della prima. Non era più giovane e non era più
responsabile solo di sé. I quadri rischiarono di andar
perduti sotto i bombardamenti, e un autoritratto del periodo bulgaro
ha ancora sulla fronte il segno di una grossa scheggia. La preoccupazione
di sopravvivere era particolarmente angosciosa per la vecchia
madre, che non riusciva a rendersi conto della situazione. Mi
ricordo ancora il mio terrore mentre, dalla cantina dove mi ero
calata per la botola, osservavo mio padre che vi arrivava passando
per la strada lunga, tra le cannonate che fioccavano, conducendo
lentamente a braccio la nonna, la quale seguitava a spiegargli
che "male non fare e paura non avere".
La
desolazione delle rovine e anche di certi aspetti della ricostruzione,
accentuava il suo bisogno di fortificarsi nel suo paese e nella
sua casa, di fissare il suo punto di vista sul moto violento che
lo circondava. Questo non significava però chiusura verso
l'esterno. Al contrario la radicazione, la sicurezza del punto
di vista gli permettevano quella estrema libertà, quella
totale disponibilità che ho cercato di descrivere. Anche
la sua solitudine, completa e dichiarata, aveva dall'altra parte
bisogno non solo dei pochi intensissimi affetti, ma anche della
presenza, intorno, di voci e figure note. La sua passeggiata giornaliera
era punteggiata di incontri, di brevi scambi di frasi, di cenni
di saluto, che costituivano un accompagnamento appena percettibile
ma necessario alla sua solitudine. Lo infastidiva invece in modo
intollerabile qualsiasi interferenza nel suo disciplinatissimo
orario di lavoro e di riposo, qualsiasi cosa che dal lavoro lo
distraesse e gli creasse quelle che chiamava "tensioni inutili".
Non ebbe più voglia di far mostre né di permettere
che fossero fatte da altri; questo avrebbe appunto costituito
un disturbo al quotidiano tribolare. Al pomeriggio, quando usciva
dallo studio, per passare nelle stanze di abitazione, se nessuno
doveva venire, chiudeva il portone di casa. La vastità
e il numero delle stanze gli allontanavano i rumori del paese
e nello stesso tempo gli permettevano di sentirli con agio e partecipazione.
A volte nella grande casa si sentiva un tonfo attutito che sembrava
lì e veniva invece da lontano, da uno dei palazzi della
via, tutti legati nelle loro strutture; o si sentivano passi,
o canti dalla strada, o motori della via di circonvallazione.
Se era estate e le finestre erano aperte, giungeva a volte chiarissimo
un dialogo a bassa voce, rimandato dal gioco dell'eco prodotta
dalla forma articolata delle grandi strutture. Mio padre passeggiava
per le sue stanze, nella poca luce del crepuscolo, accendendo
solo quando non ne poteva fare a meno. Si riposava gli occhi,
si distendeva camminando col suo passo sicuro, fortemente ritmato,
a testa china. Non usava altre stanze della casa, voleva che nelle
sue camere non ci fossero mobili inutili a intralciargli la passeggiata.
Così camminava, mugolando un motivo sempre ripetuto.
La
sua ricerca pittorica in quest'ultimo terzo della sua vita tira
le fila di tutto il pensiero precedente. Mio padre intendeva questo
processo come ricerca di massima semplificazione, necessità
di lavorare en souplesse perché dalla esperienza di tanti
anni scaturisse il dipinto che non chiamava mai bello, ma solo
a posto. Raramente era soddisfatto; la massima approvazione era
"può andare", oppure "ne fanno anche di
peggio", ma spesso decine di quadri venivano accuratamente
messi da parte - non distrutti, perché la tela costa cara
- per essere grattati con la carta vetrata. Per qualche giorno
allora si poteva vedere, in due stanze contigue dello studio,
due uomini in cappa grigia di cotone davanti a due cavalletti:
uno era mio padre che dipingeva, l'altro il suo giovane amico
Paolo che cancellava.
Vi
sono in questo periodo un certo numero di quadri fatti solo di
forme, non riferibili a nessun soggetto. Ma nella maggior parte
di loro compare ancora, in qualche modo, la figura umana. Non
sono più figure che occupano una prospettiva e la dominano;
sono invece figure schiacciate dal materiale stesso da cui emergono,
pietre, schegge, pietrisco; spesso c'è la bocca di una
caverna da cui sembrano uscire a fatica. Questo materiale pesante
a volte si alleggerisce, si fa quasi trasparente o assume colori
di pastello. La figura umana non è mai più importante
di ciò che la circonda. Un ometto appoggiato forma col
movimento del collo, con l'apertura chiara della camicia, con
le braccia, con le gambe, dei tratti di colore verticale un po'
in tralice, che continuano con la stessa forza e carattere accanto
a lui, costituendo la massa cui si appoggia. La donna col secchio
amaranto si va alleggerendo dal basso verso l'alto, finché
la sua testa quasi sparisce dentro il materiale che si fa sempre
più trasparente. Una grande figura sdraiata reca al centro
una macchia blu, da cui sembra generata; e costruisce attorno
a sé, con la irradiazione minerale di un cristallo, una
materia originata dallo stesso colore.
Questo
persistere della figura era per mio padre un tormento. Diceva
che si sentiva legato, impedito; condizionato nonostante tutto
dalla necessità che i movimenti fossero accettabili e comprensibili.
Ma questa figura umana gli tornava sempre tra le mani, e bisognava
tribolare perché non accampasse nel quadro diritti che
non aveva, e tutte le necessità fossero soddisfatte. Rispetto
alla contrazione e alla tensione dell'età matura, la sua
vecchiaia è stata sedata, spesso serena. Non mai rassegnata,
però; non ha mai visto nella vecchiaia niente di bello;
è rimasto sempre dolorosamente stupito nel vedere riflesso
nella vetrina un vecchio che era lui, o di vedere spogliandosi
delle gambe di vecchio che erano le sue. Non era d'accordo col
venditore di almanacchi, non avrebbe avuto dubbi: riavere venti
anni subito, a qualsiasi patto.
Non
vi era tuttavia in lui niente di vitalistico; era malinconico,
e spesso si annoiava. Ma aveva un gran rispetto per questa snocciolata
di giorni che è la vita; un rispetto con alcuni tratti
di parsimoniosità per questa unica cosa che abbiamo, per
mantenerne la forza, la capacità. Gli piaceva Rabelais,
e apprezzò gli studi del Bachtin, soprattutto per la ricostruzione
della filosofia rabelesiana. Leggendo si era fermato su questi
brani: "La morte qui non spezza la serie ininterrotta della
vita umana... è fatta della stessa pasta di cui è
fatta la vita"; "... doveva valutare in modo nuovo anche
la morte, mostrarla cioè nella serie temporale generale
della vita che continua ad avanzare e non inciampa nella morte,
sprofondando negli abissi ultraterreni, ma resta tutta qui, in
questo tempo e in questo spazio, sotto il nostro sole".
Back
to casa cordati index
|