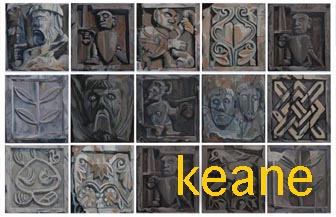Questo 2015, che volge, inesorabilmente, al suo termine, è stato- anche se i più non se ne sono accorti- un anno di importanti ricorrenze per quanto riguarda il nostro poeta: il celebre Giovanni Pascoli. Se infatti il 31 dicembre ricorreranno 160 anni dalla nascita, lo scorso 15 ottobre ricorrevano i 120 anni (celebrati con una festa all’aria aperta per le scolaresche barghigianne) dall’arrivo del letterato in Valle. Vi era giunto assieme alla sorella Mariù che nasceva giusto 150 anni fa.
La figura di quest’ultima è stata per decenni sottovalutata e, diciamocelo, infamata. Su Giovanni Pascoli e su sua sorella Maria, infatti, sono nati, si sa, illazioni e dicerie. A volte, suffragate anche da studi come quello di Cesare Garboli che con lenti un po’ sfocate aveva visto nel rapporto tra fratello e sorella l’ombra dell’incesto. Teoria poi smontata, alcuni anni fa, da un più serio studio dello psichiatra Vittorino Andreoli che aveva fatto notare i traumi che l’infanzia travagliata, la morte del padre e la giovinezza irrequieta avevano lasciato sul poeta e il carattere con ampie tendenze all’isterismo e alla frigidità di Mariù.
Certo che qualcosa, nel nido, non andava è fuori di dubbio, ma qui in Valle, certe dicerie velenose, non è mai andata giù a chi sapeva quanto doveva la nostra terra alla “candid soror”.
Non a caso il vulcanico Umberto Sereni quando Garboli se ne uscì con il suo testo organizzò un contro evento. “Ci voleva- ci spiegava, di questi tempi, due anni fa nel sessantesimo della morte di Mariù- per rispondere a quelle tesi bislacche e, ora, a qualche anno di distanza, possiamo dire di aver vinto questa battaglia giusta che dovevamo oltre che a noi stessi a Giovanni Pascoli e sua sorella, Mariù. Una donna straordinaria: uno spirito d’acciaio in un corpo di passerotto. Silenziosa, dolce, stupenda. Un dovere e un piacere ringraziarla e ricordarla. Piccola e minuta ma con quella forza che solo le donne riescono ad avere. Se Pascoli ora riposa nella nostra Valle lo dobbiamo a lei”.
Gian Luigi Ruggio, autore di una notevole biografia sul poeta e per anni curatore di Casa Pascoli, sempre nel 2013 ci aveva spiegato: “Mariù aveva capito bene che non avrebbe potuto stare lontano dal fratello, un vero e proprio genio della poesia. Uno dei nomi più importanti della letteratura di tutti i tempi. Un colosso, però, con i piedi d’argilla. Pascoli, era infatti una persona priva di qualsiasi senso pratico della vita. L’apporto morale e affettivo della sorella fu fondamentale per l’ispirazione e la creatività del fratello che solo se era tranquillo riusciva a scrivere. Per tutta la vita Mariù cercò di impedire problemi o notizie che avrebbero potuto turbare la serenità del fratello anche andando a frugare nella sua posta e stracciando, nel caso, l’eventuale lettera non gradita. Mariù, fondamentalmente, sostituiva quella madre che avevano perso in giovanissima età pochi mesi dopo la tragica morte del padre Ruggero”.
Da poche settimana è uscito un bel testo che oltre a condividere le tesi di cui sopra le amplia e approfondisce, documenti alla mano e con una leggibilità che è cosa rara in studi di questo tipo.
Il testo, presentato venerdì presso il conservatorio di Santa Elisabetta, edito da Maria Pacini Fazzi, si intitola “Maria Pascoli. La signorina di Castelvecchio”. Ne sono autori Sara Moscardini, giovane e brava ricercatrice, e Pietro Paolo Angelini che da anni studia con passione e serietà la figura del poeta. Ha confessato, Angelini, nel suo precedente scritto “E la poesia venne a cercarci…”: “durante le mie ricerche ho aperto i documenti dell’archivio di Casa Pascoli con commozione, con riservatezza, con la consapevolezza di entrare nella sua intimità e con grande rispetto. All’interno, qua e là, tanti quadrifogli e fiori essiccati che mi hanno dato una forte emozione”.
Moscardini, che ha studiato le carte di Maria sempre passate in secondo piano (si parla di oltre 14.000 missive) e ha seguito la digitalizzazione il progetto sull’Archivio Pascoli, promosso dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana (per un totale di oltre 37.000 documenti), chiarisce nella sua presentazione al testo: “scrivere di Maria Pascoli è rischioso, non bisogna farsi ingannare dall’immagine stereotipata; non perché si debba temere di incontrare il suo fantasma mentre ci si aggira tra le stanze della biblioteca di Caprona, come vogliono alcune voci popolari. La preoccupazione piuttosto è di cadere in un tranello: credere di lavorare sulla sua figura ed arrivare invece a parlare del più famoso fratello poeta, ma chi la conobbe e ha studiato le carte di Casa Pascoli comprende sin troppo bene come Mariù abbia avuto una sua decisa e specifica identità”.
Maria Santa Adele Annetta Pascoli, questo anagraficamente il nome per esteso di Mariù nata il primo novembre 1865, fu al fianco del fratello per 27 anni. Iniziarono a vivere, assieme alla sorella Ida, a Massa, dove Pascoli aveva assunto la cattedra al liceo “Pellegrino Rossi”. Gli sopravvisse di 41 anni, tutti vissuti da sola nella bicocca sul colle di Caprona.
Figura forte e conscia delle proprie capacità, Maria, dopo il 1912, ebbe un ruolo attivo dal punto di vista editoriale e redazionale, a lei scrivevano coloro che erano interessati a utilizzare i testi del fratello, correggeva bozze, sceglieva testi.
A Castelvecchio, viveva da sola, unica compagnia era quella della domestica Attilia Caproni figlia del celebre Zì Meo (il contadino cantato dal Pascoli in alcune poesie); e poi i cani, i quali, uno alla volta, gli tennero compagnia per tutta la vita.
Il primo era stato il celebrato Gulì, il “dottor” Gulì, poi il sanbernardo Argo, il meticcio Trigo e l’incrocio di lupo Brigo (di cui si ha anche un bel ricordo, quasi un ritratto, di Lorenzo Viani) e poi Bitrì, l’unico che le sopravvisse.
Da buona massaia romagnola si faceva il pane da sola, e, testardamente, non accettò mai né luce elettrica né acqua corrente. Libri e immagini devozionali abbondavano in casa “ma, coi preti,- sottolineava- sono punto domestica”.
Ebbe invece un rapporto inizialmente ostile con il fascismo della prima ora, quello squadrista, ricordando una massima di Giovannino secondo il quale “col male non si rimedia al male” ma, poi, aderì al fascismo istituzionalizzato divenendo nume tutelare di Barga e dei barghigiani.
Spiega Angelini: “L’adesione di Mariù al fascismo fu un atto spontaneo, naturale, forse anche perché come Mussolini, anche lei era romagnola. Si può inoltre dire che il fascismo avesse individuato nel Pascoli un poeta giusto per poter presentare e diffondere nella scuola gli ideali popolari del movimento fascista. Maria non chiese quasi mai nulla per sé. Sicuramente l’educazione scolastica di stampo fascista, adottando Pascoli come uno degli autori prediletti, favoriva la diffusione della memoria di Pascoli, e favoriva anche ristampe, riedizioni e così via, e questo si sposava pienamente con i desideri di Maria. I rapporti col fascismo sicuramente le hanno guadagnato scorciatoie burocratiche: ad esempio sembra che non sia stato estraneo un intervento di Mussolini nella controversia tra Zanichelli e Mondadori per i diritti sulle opere di Pascoli”.
Mariù conobbe il duce a Roma il 9 giugno 1925. La ricevette alle 17 con “deferenza e cordialità”. Fu il primo di una serie di incontri tra i due. Uno anche in Valle, durante la visita di Mussolini in Lucchesia. Varcando la porta della casa di Castelvecchio, il duce disse: “Silenzio! Qui si entra nella casa della poesia…”.
A ricordo dell’importante visita fu posta una lapida accanto alla porta d’ingresso della cappellina che però fu fatta togliere, sempre da Mariù, prontamente, alla fine della guerra.
Ma Mussolini non fu il solo a far visita a Casa Pascoli: vi si recò, per ben due volte, l’allora principessa Maria Josè, futura ultima regina d’Italia. Il triumviro Cesare Maria De Vecchi, ministro del regime e Giuseppe Bottai di cui Mariù rimase molto soddisfatta annotando, entusiasticamente: “è un ministro veramente eccezionale, affabile, affettuoso, senza atteggiamenti di superiorità”: “una mosca bianca” nel panorama dei gerarchi fascisti.
Durante la campagna dell’Oro alla Patria non potendo sacrificare la fede nuziale pensò di concedere una delle medaglie d’oro del Poeta vinta a uno dei tanti concorsi di poesia latina in Olanda. “Credo di aver fatto cosa gradita al mio Giovannino” scrisse nel suo diario.
Fu, sempre, durante il fascismo che la casa di San Mauro fu elevata a monumento nazionale e fu sempre durante il ventennio che a Castelvecchio iniziarono i lavori dell’asilo tanto voluto dalla sorella e dedicato alla memoria dei genitori.
In quegli anni, in tantissimi si rivolgevano a lei per favori, richieste di vario tipo. Tanto da ammettere: “il mio tavolino sembra quello di un ministro”.
Durante la seconda guerra mondiale non lasciò mai la casa di Castelvecchio. Don Leonello Chiappa ricordava che mentre si preparava a celebrare messa, un giorno, venne una donna a consegnargli un manifesto in cui il comando tedesco ordinava lo sfollamento del luogo: chi dopo le sette del giorno dopo fosse stato trovato in giro sarebbe stato subito fucilato secondo la legge marziale. Finita la messa corse per il paese a dare la notizia, l’unica che decise di rimanere fu Mariù. Dovette annotare, il reverendo, nelle sue memorie “mi incaricarono di dissuaderla ma fu inutile”.
Nei giorni successivi la superiora di ottant’anni di un vicino convento ci provò anche lei a cercare di dissuadere la celebre sorella del Poeta: tutto inutile. E così, Mariù, trascorse il periodo della guerra in una terra di nessuno, sulla linea del fronte. Dormiva su una poltrona al piano terra per potersi muovere più agilmente in caso di cannoneggiamento.
Il giornalista Furio Bartorelli così la descriveva, qualche mese dopo il conflitto: “è esilissima, con una grigia veste francescana, dalle maniche escono maniche magrissime, quasi evanescenti”.
Sempre più ritirata e eremitica, in paese appariva raramente. Non aveva grandi amicizie ed era circondata da un alone di misticismo e di devozione.
Gualtiero Pia la ricordava mentre con una mano sgranava il rosario e con l’altra toccava attraverso una piccola fessura la bara del fratello. Nelle lunghe sere d’inverno, confessò poi, rimaneva al buio per meditare e pregare.
E, proprio, in una notte di dicembre se ne andò. Era il 5 dicembre 1953. Aveva 88 anni. Aveva scritto “e ora addio. Possa io prepararmi bene alla partenza e raggiungere subito il mio Giovannino e i miei cari nel regno di Dio. Perdonatemi tutte le offese che avessi potuto arrecarvi, come anche io perdono tutto a tutti. Pregate sempre per me, anzi per noi”.
Image by Pier Giuliano Cecchi – Article by Nazareno Giusti